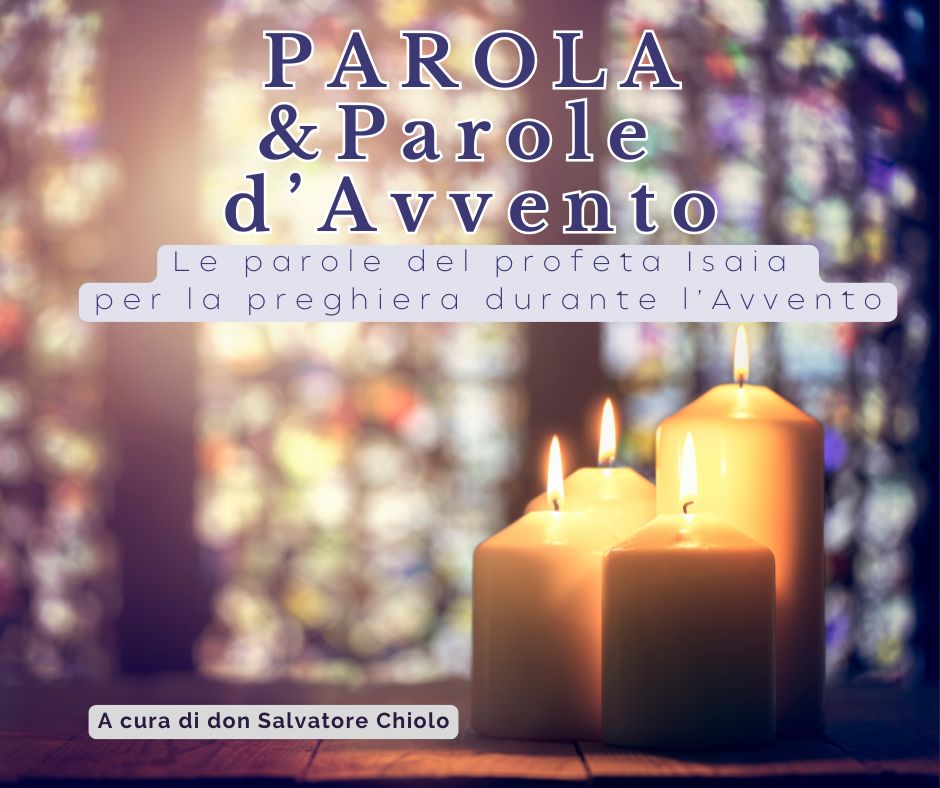
La venuta del Signore agli occhi del profeta è un prodigio di amore esteso a tutti. La prima settimana della liturgia d’avvento lo mette in risalto con una serie di brani tratti dalla prima parte del libro del profeta, che è poi quella direttamente composta da Isaia (Is 1-39). Quindi un vero e proprio compendio di misericordia senza confini, senza limiti e senza differenze di lingua, di razza, di etnia o di condizione sociale, economica e politica.
La seconda settimana d’avvento, nel solco immensamente profondo di questo stupendo filone biblico di matrice profetica molto attuale tracciato durante i giorni precedenti, scava ancora più in profondità per ritrovare nelle stesse parole di Isaia un destinatario preciso, un contesto e una comunità ben identificata con la quale sentirsi in relazione e a cui indirizzare le forti parole di consolazione sull’intervento di Dio. All’indomani della domenica, la Parola della prima lettura durante la liturgia eucaristica del lunedì scopre la categoria degli smarriti di cuore. Ad essi è rivolta la ricompensa divina con versi molto puntuali: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi» (Is 35,4). Lo smarrimento del cuore, allora, è recuperato da una salvezza che dissolve inizialmente la paura e, dopo, la minaccia bellica, mortale e umiliante di un nemico di cui vendicarsi: una scelta che riprende l’idea di corrispondere e ricompensare la violenza di chi ha tolto la luce e costringendo a camminare nelle tenebre tutto un popolo intero (Is 9,1). Ai ciechi, ai sordi e ai zoppi, a mò di esempio di quanti sono stati flagellati ingiustamente, verrà consegnata dal Signore la vita nel corpo e nell’anima e perché questo miracolo trovi il proprio interlocutore disponibile, le parole del profeta risuonano con più ardore quando si proclama, al martedì: «Consolate il mio popolo» (Is 40,1-2). Come a dire che se non ci sono limiti all’azione con cui proteggere tutti da parte di Dio, ma che ancora di più le difese cedono e si abbattono se si tratta di coloro che nel popolo sono ormai sfiniti dalla vita e dalle conseguenze di errori, malanni e fallimenti. Agli smarriti di cuore, nella liturgia della Parola del mercoledì, si affianca quella dello stanco e dello spossato: due emblemi di una visione costante della condizione dell’umanità del popolo eletto da cui il profeta non riesce a distogliere lo sguardo (Is 40,25-31). Condizione che ritorna anche nella liturgia del giorno dopo, giovedì della seconda settimana, con la menzione dei miseri e dei poveri a cui è riservato il trattamento di attenzione urgente e prioritario, rispetto a tutto e a tutti (Is 41,13-20). Ad essi il Signore, il redentore ed il santo si rivolge per mutarne la sorte con raccomandazioni tonanti: «ti insegno per il tuo bene, ti guido per la strada su cui devi andare», così per come la liturgia del venerdì propone (Is 48,17-19). Non un primo soccorso da campo di battaglia, ma una cura prolungata nel tempo e nello spazio è quanto Dio intende realizzare; non un intervento per tamponare e, magari, dedicarsi a qualcos’altro subito dopo, ma un’azione più coinvolgente ed integrale che ricomponga il tessuto umano distrutto da promesse disastrose: un massiccio ed intenso lavorio a cui fa seguito anche logisticamente il ritorno dalle terre d’esilio da parte dei nuovi poveri, un tempo ricchi signori presi in custodia e volutamente allontanati dalla patria d’origine nei giorni della capitolazione. L’intento è mirato a vivere la presenza in modo attivo, attraverso gesti di salvezza non affidati al caso, bensì ad uomini eletti di cui già si fa menzione tra le righe e senza riferimenti precisi, ma che nella liturgia stessa rientreranno in gioco attraverso il paragone con Elia. Il sabato, infatti, è affidato alla proclamazione di un brano tratto dal libro del Siracide con cui si anticipa l’ingresso di Giovanni Battista e dei suoi discorsi nell’insieme delle parole dell’avvento del Regno di Dio, con la persona di Gesù Cristo. Da questo momento in poi, il richiamo alle figure bibliche di riferimento sarà un espediente utile a rafforzare l’idea che Dio ha voluto per il suo popolo una cura puntuale, forte, immediata e diretta, piuttosto che una prognosi palliativa e di accomodamento. Il tempo degli ospedali da campo è da attribuire ad iniziative frettolose e provvisorie che impoveriscono il senso dell’intervento medicinale di Dio e dei suoi eletti: iniziative che Ezechiele e Geremia condanneranno rivolgendosi ai pastori del popolo senza mezzi termini. La promessa di cui Isaia si fa portavoce incide nel tessuto sociale sia direttamente per i poveri del popolo che indirettamente, per le autorità distratte da interessi alieni dalla condizione di sofferenza in cui ci si è trovati per loro responsabilità, tra l’altro. Essi guarderanno al gesto con cui Dio si sporcherà le mani pur di risollevare dal fango quella condizione a cui il popolo era stato sottoposto a causa della loro stessa negligenza; e così vedranno come la resurrezione politica sia strettamente legata dalla risurrezione spirituale e il servizio vero e sincero nei confronti del popolo abbia senso alla luce dell’ascolto e della realizzazione onesta e leale delle indicazioni di Dio a tutto il popolo.
