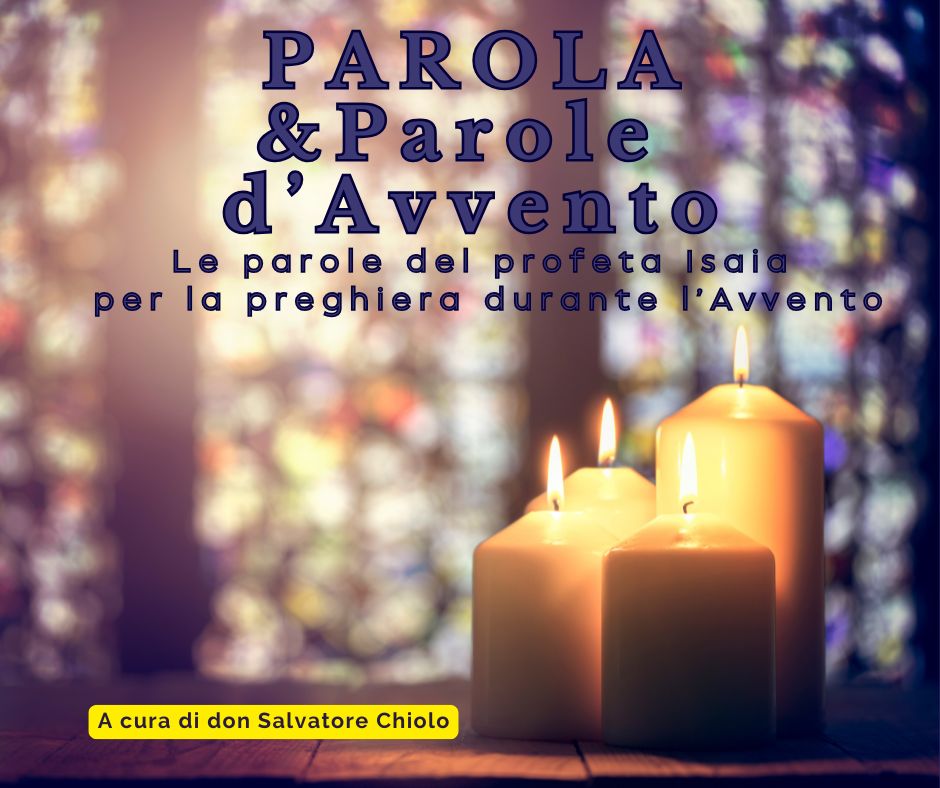
«Verranno molti popoli e diranno: Venite, saliamo al monte del Signore» sono le parole chiave che da lunedì scorso hanno aperto la strada alla riflessione su una situazione generale in procinto di coinvolgere tutti, senza lasciare fuori nessuno. Questa situazione sembra assomigliare ad un grande viaggio, una sorta di pellegrinaggio verso un luogo ben preciso: il monte del Signore, ovvero un luogo alto, visibile da ogni angolo della regione, soprattutto man mano che ad esso si ci avvicina: una situazione in cui la fatica è soppesata e messa di lato come se la cosa più importante fosse proprio il viaggio, il percorso, e quindi il movimento che la Parola promessa compie e fa compiere: «Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion.» (Salmo 84,8). Il senso del dire che la voglia di andare cresce e lievita muovendosi, cattura l’attenzione delle prime luci di avvento; gli occhi stessi si muovono alla ricerca di colui che è pronto ad incontrare la comunità tutta in movimento, animata pure da un certo desiderio di far strada: un desiderio rubato alla banalità del Natale ridotto ormai al consumo, al carrello degli acquisti nonostante anche in Europa le famiglie stringano nuovamente la cinghia negli ultimi tempi.
Quando parole come quelle in cui: «Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà.» (Isaia 11,6), ascoltate nella celebrazione del martedì, irrompono durante la messa, è chiaro che qualcosa sfugge, come se si fosse rimasti indietro. Un senso di smarrimento generale accompagna il desiderio di fare strada, ma la Parola promessa ribadisce: «Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte… Egli strapperà su questo monteil velo che copriva la faccia di tutti i popoli … Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto» (Isaia 25,6-8, nella liturgia di mercoledì). Tutti i popoli… ogni volto: tutti ma chi? tutti e come mai?
«I piedi degli oppressi, i passi dei poveri» si muovono per le strade della «città forte» (Isaia 26,1.6, liturgia di giovedì). Insomma, è impressionante la colata incandescente di novità che smuovono gli “equilibri” e le comodità del cristiano accomodato. Equilibri “democratici”, si direbbe, a vantaggio di chi merita; equilibri, però, fin troppo borghesi se alla fine chi non è “dei nostri” è scartato. Per la Parola promessa, tutti sono ben accetti dal Signore e per Lui non esistono meriti. «In questi giorni gli occhi dei ciechi vedranno» (Isaia 29,17-24), continua a farsi sentire la promessa del venerdì, ancora a danno di un ordine da ribaltare e correggere, e quindi sabato infine, «il Signore curerà la piaga del suo popolo» (Isaia 30,26), cioè quella che riguarda la quota debole della comunità, tutto un numero e un modo di essere nella comunità rimasto altrove a fissare il monte senza riuscire più a sentire la voce che lo guida verso lì.
È chiaro che iniziando un periodo ben preciso come quello che con l’Avvento si definisce “anno liturgico” il tema e il modo di procedere sono immediatamente messi a fuoco, onde evitare fraintendimenti e sbandate. Ma è ancora più chiaro che spesso è così brusca l’inversione da fare che si finge di camminare per la direzione giusta, uscendo dallo spirito ecclesiale fin da subito, senza nemmeno godersi la bellezza della festa del Natale: accogliere la Parola promessa, la Parola data da Dio, che poi è quella che ha in sé la forza del cambiamento e dell’inversione. La portata profetica delle pagine d’Isaia, in questa prima settimana scelte tra i capitoli di cui lui stesso è stato l’autore – rispetto ai brani che verranno proposti nelle altre settimane – si lascia apprezzare sia per la ricchezza delle immagini con cui imprime un profondo movimento nella lettura del messaggio di Dio, sia per l’orientamento naturale a cui spinge lo sguardo di ognuno: la visione dello Spirito. È con la sua forza che ognuno nella comunità viene lentamente guidato e piano piano svezzato così da ritrovarsi a camminare in seno ad un vero e proprio popolo di persone che scelgono di fidarsi della Parola promessa.
Il cristianesimo è una visione della vita su cui la storia ha deciso di scommettere per secoli; e nonostante la chiesa si sia spesso divisa al suo interno fino a decidersi per cammini paralleli in comunità sorelle, ma non unite, il suo messaggio ha resistito alle forze centrifughe evitando di sbattere e svanire. La profezia di un bambino a capo del popolo, di un fanciullo che orienta e conduce il percorso della pace tra chi è vestito da lupo e chi da agnello, tra chi fa la parte del leone e chi del vitello acquista sempre più forza ed ha sempre di più luce, mentre nel pianeta il potere dell’informazione, innanzitutto, e poi quello delle armi lasciano indietro la verità, la giustizia e l’innocenza. Nel volto immaginato di un fanciullo (nahar nella lingua del profeta e pais nelle versioni greche del popolo ebraico in diaspora) l’umanità ritrova sé stessa e si scopre con sua grande meraviglia scelta da Dio per condividere il suo stesso destino: la vita della comunità oltre la morte. La visione ha in sé il potere di compiere quanto accenna attraverso la luce degli occhi; colui che vede è anche colui che illumina, e il carisma profetico degli sguardi cristiani, oggi, riesce a vedere la vita anche nelle file alla posta, in farmacia e nei supermarket. Di questi occhi è dotato lo Spirito con la sua visione e con questi occhi il cristiano è stato mandato a portare luce della città forte nel mondo e tra gli uomini stanchi di false promesse.
